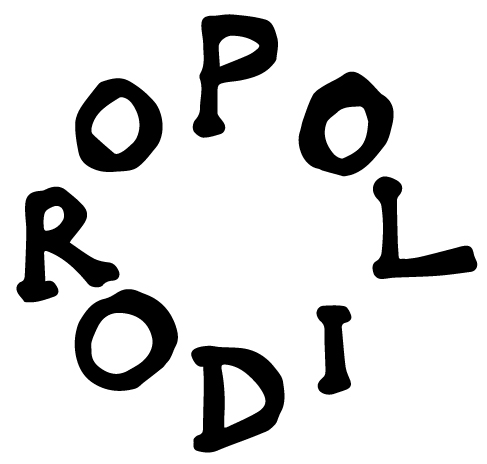EPIFANIE NEL SILENZIO DELLE IMMAGINI
Il sogno e il compito – quanto mai difficile – della critica d’arte è quello di catturare il movimento del pensiero degli artisti, il bagliore dei loro processi mentali, i nodi intellettuali che li ossessionano e li affascinano nel corso della loro esistenza. Senza dubbio, l’“idea fissa” di Julie Polidoro – come lei stessa, tempo fa, mi ha confessato – è una questione fondamentale per tutte le arti: come tradurre lo spazio. È intorno a tale idea che si sviluppa l’intera sua pratica artistica e, dunque, anche questa mostra. Vediamo in che modo.
Innanzitutto, è necessario specificare che lo spazio “tradotto” dalla Polidoro è lo spazio del mondo ridotto geometricamente a superficie piana, a immagine, a mero oggetto di rappresentazione. Un mondo che – come ha chiarito Giacomo Marramao in campo filosofico – ha cessato «di essere l’habitat in cui le nostre vite sono immerse, la dimensione che circuisce e coinvolge i destini delle nostre umane esistenze in un intreccio inestricabile con altre forme di vita ed esistenze non umane, per trasformarsi in oggetto di conoscenza razionalizzabile, misurabile, calcolabile e, di conseguenza, assoggettabile e plasmabile dai dispositivi della rappresentazione […] produttivamente finalizzata al dominio del mondo-oggetto, allestita dal soggetto».
Ma alla questione dello spazio è strettamente intrecciata quella del tempo. Perché allo spazio omogeneo e unitario corrisponde il tempo vuoto e omogeneo del capitale, che colloca qualsiasi evento in un’implacabile e fissa gerarchia cronologica; un tempo utopico, dacché non si trova in alcun punto dello spazio reale. Il mondo “tradotto” dalla Polidoro è, dunque, un mondo in cui – riprendendo ancora Marramao – «si dà esperienza solo degli eventi muti – senza parola e senza valore, e pertanto misurabili e legiferabili – che hanno luogo nella dimensione, in ultima analisi fisica, della fatticità naturale». Un mondo, dunque, in cui degli eventi simbolici ed emotivi del vissuto non può darsi esperienza, perché per essi non si dà luogo. Non è un caso che i “soggetti” scelti dalla Polidoro in questa mostra siano soggetti massimamente “muti”.
Da una parte, i corpi dei migranti, che giacciono abbandonati sui pavimenti spogli dei cosiddetti centri di accoglienza. “Non-persone”, secondo la definizione di Alessandro Dal Lago: corpi senza nome e senza volto, ridotti allo statuto di oggetti e “parcheggiati”, come dei pacchi all’interno di una grande catena di distribuzione, in “ripari” provvisori, in attesa di riavere la loro vita. Le frontiere, i centri di detenzione per persone migranti e gli spazi di segregazione, infatti, sono “stati di eccezione”, in cui si materializzano gli effetti di quella spazializzazione depotenziante, depauperante e mortifera a cui Achille Mbembe ha dato il nome di “necropolitica”. Sono “zone di morte sociale” che producono individui fuori-legge, ricondotti a quella che Giorgio Agamben, riprendendo il diritto romano, ha chiamato “nuda vita”: quella vita radicalmente depolicizzata che è inclusa nell’ordinamento giuridico solo nella forma della sua esclusione. Una vita esposta in maniera assoluta al potere sovrano dell’Altro e, in quanto tale, non sacrificabile, ma semplicemente uccidibile. E, di conseguenza, il soggetto che ne è portatore in qualche modo è già morto.
Dall’altra parte, all’interno della mostra, si trovano una serie di paesaggi, raffiguranti tempeste di sabbia incombenti, le quali non sono altro che effetti di quello che solitamente ed eufemisticamente viene chiamato “cambiamento climatico” e che, invece, più propriamente, dovrebbe chiamarsi “riscaldamento globale”. Sì, è l’inquinamento prodotto dalla nostra specie con il conseguente riscaldamento globale, l’“iperoggetto” par excellence secondo Timothy Morton, l’altro grande “tema” scelto dalla Polidoro; quel riscaldamento del pianeta direttamente responsabile dell’intensificarsi dei danni provocati dagli uragani negli ultimi anni. Un tema che apparentemente sembrerebbe distaccato e lontano da quello dei migranti, e che, invece, è ad esso strettamente connesso. Per due motivi principali. Innanzitutto, perché, come è stato ampiamente dimostrato, il riscaldamento globale nel prossimo futuro sarà causa di enormi migrazioni, destinate a provocare un aumento delle tensioni sociali e geopolitiche. E, in secondo luogo, perché sia le immagini dei migranti che quelle raffiguranti le tempeste di sabbia, che la Polidoro ha usato come modelli per le sue opere, sono immagini provenienti dal web. Ecco, dunque, che si profila meglio il carattere muto di queste immagini: entrambe sono immagini di “catastrofi”, che, però, nella fruizione digitale, non vengono percepite come tali. Si potrebbe dire che sono immagini di un Reale traumatico che è stato necessariamente addomesticato, in modo da essere reso consumabile. Insomma, sono immagini de-fatticizzanti, che schermano dalla “sporca” e “scomoda” realtà, insopportabile da vedere. Immagini da cui siamo bombardati quotidianamente, ma che, proprio perché hanno perso la loro “violenza”, non si fissano drammaticamente e non si sedimentano nella nostra memoria. Infatti, per quanto possa sembrare assurdo, i tratti comuni di queste immagini-simbolo sono l’iconicità e la conseguente viralità, ma non certo la commozione o l’indignazione.
E, allora, si chiarisce il lavoro di traduzione della Polidoro: un lavoro che mira a far sorgere, all’interno dell’opera, la percezione di quello “scarto” irriducibile, quel gap, che sussiste tra l’evento realmente vissuto – tremendo, drammatico, potenzialmente fatale, indicibile –, al quale queste immagini rinviano, e la sua rappresentazione, consumabile e virale, esperita sul web. Un lavoro, in altre parole, che mira a recuperare quel “non visto” – come recita il titolo di un’opera in mostra – presente all’interno del silenzio assordante di ciò che si vede. E ciò la Polidoro riesce a ottenerlo inventando nuovi modi di cartografare lo spazio e il tempo. A me, infatti, sembra che la sua sia una vera e propria “critica della ragione cartografica” (Farinelli), cioè della mappatura oggettivante e sezionante del mondo. Consapevole del fatto che le geografie plasmano i processi e le stesse azioni sociali, la Polidoro, ad una “leggibilità del mondo” (Blumenberg), dove il dominio della rappresentazione si risolve nell’ingiunzione a fare a pezzi il mondo e ad appiattirlo, contrappone “nuove” cartografie, che corrispondono a “nuove” logiche, a “nuovi” modi di pensare il mondo altrimenti. E proprio questo rende, a mio avviso, la sua pittura estremamente attuale.
Se le immagini del mondo restituite dai dispositivi di rappresentazione sono immagini “sature”, uniformi, la cui unica funzione è la trasmissione e la propagazione di informazioni, la Polidoro produce immagini “insature”, incomplete, instabili, immagini in cui vi sono dei “vuoti”; immagini che fungono dunque da contro-informazione, da contro-narrazione, da vero e proprio atto di resistenza. La Polidoro, infatti, mantenendo delle campiture vuote che mostrano il supporto “vergine” oppure dipingendo su pezzi di scotch che successivamente sposta all’interno dell’opera, crea dei buchi all’interno delle immagini. L’obiettivo è di sottrarre o dislocare informazioni per disturbare la sintassi e lasciare così allo spettatore uno spazio di movimento e di riflessione. Infatti, interrompendo – tramite scarti e slittamenti metonimici, che fungono da elementi perturbanti e spaesanti – la lettura lineare, rapida e smaterializzante propria della visualizzazione sul web, la Polidoro costringe lo spettatore a catturare prospettive altre: a prendere, cioè, in considerazione, all’interno dell’immagine, altri punti di vista possibili, quei punti di vista che normalmente vengono silenziati ed esclusi, e che, invece, impediscono la perfetta chiusura della rappresentazione.
Bucando l’immagine, insomma, Julie Polidoro ci obbliga a riconoscere la singolarità di quel che è nascosto nel nostro subconscio automatico, l’altra scena sottesa alla struttura del nostro presente, quella “prosa del mondo” – fatta non di spazio-tempo uniforme, ma di luoghi singolari, qualitativamente connotati, di temporalità radicalmente eterogenee, asincroniche e dissonanti, di esperienze sommerse, di densità differenti e senza sintesi, di dinamiche relazionali – che costituisce il fattore costitutivo del nostro agire e del nostro concreto, corporeo, essere-nel-mondo.
Giuseppe Armogidaè filosofo e curatore indipendente.
Attualmente insegna Estetica e Fenomenologia dell’immagine presso l’Accademia di Belle Arti L’Aquila e Semiotica dell’arte presso la NABA di Roma.