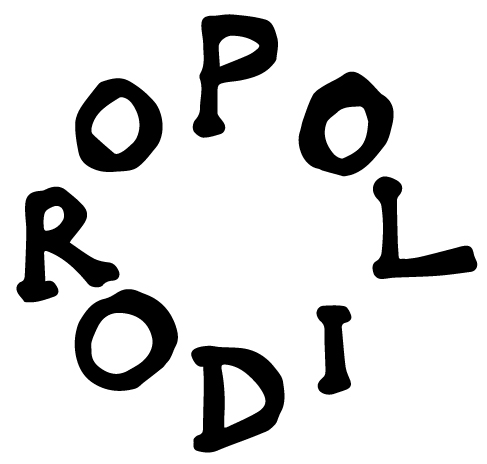CARTOGRAFIA FANTASTICA
Da parecchi anni, Julie Polidoro, sempre oscillante tra Roma e Parigi, va elaborando un ampio catalogo di cartografie fantastiche, una mappatura del nostro mondo, dipingendo con grande poesia personalissimi tentativi di elaborare il caos e di mettere ordine nello spazio. Come sostenne Ruggero Bacone nel suo Opus Maius (1267): “Lo spazio è l’inizio della nostra esistenza, proprio come un padre”.
Le mappe e le carte geografiche sono un tentativo, sempre approssimativo, di cogliere e rappresentare la complicazione del mondo. Questi indispensabili strumenti di orientamento scontano, nella loro natura bidimensionale, un difetto non facilmente rimediabile. Nel mio sussidiario delle elementari, per spiegare l’impossibilità di rappresentare su un foglio o una tela la rotondità della terra, si suggeriva l’esperimento di schiacciare la buccia di mezza arancia su un piano e assistere all’inevitabile spaccatura di quella semisfera porosa in una sorta di, bugiarda, circonferenza a spicchi.
C’è poi la questione del bisogno di staccarsi dalla superficie che si vuole rappresentare per poterla osservare da un punto sufficientemente alto (a “volo d’uccello”) che permetta di cogliere bene lo spazio nella sua interezza. Questo “allontanamento” è necessario non soltanto per le questioni cartografiche, come scriveva infatti Rainer Maria Rilke: “Si sa quanto male riusciamo a vedere le cose tra le quali viviamo, e spesso soltanto chi viene da lontano sa dirci che cosa ci sta attorno”. Da sempre però ci siamo dovuti dibattere tra scegliere d’innalzarsi e allontanarsi per vedere meglio (ma, distaccandosi, perdere il senso della realtà), e stare con i piedi vicini alla terra (ma smarrire così la visione d’insieme).
Putroppo, tutti i tentativi che facciamo di dare un ordine (kosmos) al mondo sono sempre soggettivi e parziali, e non riusciamo a dar conto del ricco e vario disordine (kaos) nel quale viviamo. L’arte (non aspirando alla verità oggettiva, come fa la scienza) ci permette di superare questa dicotomia, suggerendoci nuove rappresentazioni del mondo, inediti tagli prospettici, sguardi lontanissimi e vicinissimi allo stesso tempo.
Julie Polidoro ha cominciato a dipingere mettendo in ordine i singoli oggetti. Tra i suoi primi dipinti c’è una bicicletta rossa che, con il suo arrugginito telaio, mostra delle linee che già delimitano dei campi, delle provvisorie ripartizioni dello spazio. Poi, via via, ci ha mostrato altre cose, còlte accoppiate nella loro solitudine spaziale: le grifagne Due forchette (1997); il malinconico Due magliette appese (fig. 1), 1999, primo esempio di oggetti sospesi a un filo che prefigura le recenti grandi tele penzolanti dal soffitto degli spazi espositivi; l’inquietante Due file di bicchieri (2001). A questi seguono Frammento di spazio II (2001); Parking-people I, II, III (2004); Domestic spaces (2004): stratificazioni di linee colorate che delimitano gli ambienti e i passaggi. Quando compaiono figure umane, e sono per lo più sedute, sembrano pezzi di scacchiera in attesa di entrare (o uscire) in gioco. L’essere umano, anche quando ci sono delle persone, non è mai al centro dei dipinti di Julie Polidoro. Nelle sue opere non c’è una gerarchia fissa della visione, ma una gerarchia mobile, come nella vita (e questa gerarchia tende a marginalizzare la figura umana).
Tra le opere successive, grande effetto pittorico, oltre che emotivo, hanno le Maps of food (2006), nelle quali si immagina di individuare, e marchiare con un’icona, lungo le linee delle mani e delle braccia, i punti dove si possano collocare i cibi ingeriti. In Body city map (fig. 2), 2003, si appongono le mani e i piedi su una carta stradale, come tracce indelebili del passaggio su quel territorio. La stessa cosa avviene, su scala planetaria, con World-body, del 2005. Queste mappature del cibo sfoceranno nell’apprezzata serie Frigo Abitato (in particolare: Frigo Abitato II, 2009, fig. 4, e Frigo Abitato IV, 2012): enormi frigoriferi a due ante che fanno da sfondo a una mappa di cibi, parti anatomiche e oggetti, e che ricordano certi fogli di appunti di pittori antichi, come Leonardo da Vinci, i quali abbozzavano, sovrapponendo sullo stesso pezzo di carta, in tempi diversi e con inchiostri o matite di vario calibro, figure abbastanza disomogenee (cavalli, piante, brani di corpi, progetti di macchine, figure umane) con un effetto caotico assai suggestivo.
A un certo punto, gli oggetti sembrano perdersi in un labirinto che nasce dagli spazi liberi che li separano – come in Dormitorio con arcobaleno (2008) o in Dormitorio (2004) – o si definisce tra le maglie, attraverso le quali Julie Polidoro vede la realtà che la circonda. Così organizza i propri dipinti (su lastra di lavagna, lucido plexiglass o tela grezza libera dall’intelaiatura), sbirciando e componendo attraverso le “cornici visive” di una rete o i buchi regolari di una cortina di plastica. I labirinti visivi, Labyrinth (2008), spesso costituiti e osservati attraverso una grata (come Connessioni III, fig. 3, 2005, o Labyrinth behind a grid VIII, 2008), danno la possibilità di considerare i vari frammenti della realtà più connessi e ordinati, pur essendo separati da una trama regolare colorata. L’ossessione di appropriarsi, con il disegno e i colori, di sempre nuovi spazi raggiunge le estreme conseguenze in Elementi toccati oggi 18 maggio 2005 (2005), dove la mappatura non è più la mappatura di un territorio, ma è un catalogo di oggetti legato, più che allo spazio, al tempo.
Nello scritto Tele appese, che accompagnava la mostra dei suoi dipinti a Milano, presso i Frigoriferi Milanesi nel 2011 (fig. 5), Julie Polidoro affermava: “I miei lavori più recenti sono delle grandi tele dipinte, appese (senza telaio), che pendono nello spazio. (…) L’esperienza che ho del tempo e dello spazio oggi è vicina ad una torsione elastica; ogni giorno vivo un rovesciamento dei rapporti fra il vicino e il lontano. Mi interessa il paesaggio come funzione del tempo. La percezione del tempo vista come qualcosa che appare e sparisce, che è discontinua, come la mia percezione del visibile, come il mio essere al mondo”.
La grande tela Tempo sfumato I (2009) è un’opera dinamica dove le immagini scorrono parallelamente su due piani: alla base ci sono dei riquadri irregolari, come un patchwork di toppe verdi di varie misure e sfumature di colore (degli appezzamenti di terreno visti dall’alto); sopra, a sprazzi, banchi di nuvole biancastre. Il contatto tra questi due piani è costituito dalle ombre delle nuvole che si proiettano, scure, sul terreno sottostante, come avviene ne Le nuvole mi guardano (2009) e in Je te vois, dello stesso anno: un tappeto di quadrati di campi coltivati, sfumanti sempre tra il verde e il grigio, sovrastati da radi ciuffi di nubi bianche che proiettano le loro ombre sul terreno. Come spiegava Julie Polidoro, nello scritto sopra citato: “Ci sono dei buchi di visione, delle interruzioni del visibile, delle mancanze d’informazioni (anche di pigmento, che vengono fuori con l’aiuto delle pieghe o dello scotch) materializzate dalle nuvole. La forma indecisa, in sospensione, materia mobile per eccellenza delle nuvole, porta alla circolazione dello sguardo”.
Dall’alto, sopra le nuvole, è possibile immaginare degli spazi sempre più mentali, quasi dei modelli di mappe digitali: come Strade immaginarie di Milano (fig. 6), del 2011, che fa esplicito riferimento a Google Maps o Strade immaginarie di Roma I e II (2011), che permettono di intravedere solo il reticolo delle strade più importanti, che poi non sono quelle reali. Così Julie Polidoro può permettersi, e permetterci, di sognare una geografia fantastica e indistinta, come in Tutti i paesi del mondo a contatto I, II (cat. nn. 3, 4), del 2011: una sorta di pelle raggrinzita che sulle suture (che delineano un’idea di meridiani e paralleli) fa esplodere le macchie di colori di nazioni e continenti ormai indistinguibili. Oppure in Toutes les mers du monde en contact (cat. n. 1), 2012, dove le terre e le acque, ridotte come a cristalli di una glaciazione che si sta sciogliendo, sfalsano i piani della superficie e muovono lo sguardo verso un vortice centripeto di colori.
Il cielo e le nuvole sono all’opposto della nozione di riquadro, di confine, di limite. La produzione più recente di Julie Polidoro tira le fila di questo percorso filosofico e geografico, che tenta di guardare la realtà dall’alto e mandare in frantumi tutte le divisioni artificiali del territorio, permettendosi di realizzare dei veri e propri planisferi fantastici. Per far questo, la pittrice arriva a ‘piegare il cielo’, attraverso un atteggiamento di sospensione e slittamenti progressivi della sua visione del mondo e della vita. Così si va: dal più “tradizionale” Le monde tourne V (2012), con i continenti in rosso su uno sfondo grigio solcato dai meridiani e dai paralleli; a Slittamenti I (cat. n. 10), 2013, dove i mondi sembrano dei palloni un po’ sgonfi, osservati da lontanissimo, in un universo giallo e scolorato; alla serie In ogni paese tutti gli altri (2011), con l’orbe terracqueo che sembra un gomitolo di fili colorati che cancella i confini e le superfici. Sul piano bidimensionale, la stessa cosa avviene alle mappe Scarabocchio preciso I e II (figg. 7, 8), dove decine di linee colorate si intersecano e sovrappongono, fino a giungere al sogno utopico di Paesi del mondo senza i confini (fig. 9), 2011, dove dei continenti rimangono solo quadratini multicolori, come un allegro mosaico che rivendica la libertà di non farsi rinchiudere entro un ambito predeterminato. Nel far questo l’artista dà corpo a un sogno che risponde alla perentoria ingiunzione di Oscar Wilde: “Una carta del mondo che non contiene il paese dell’Utopia non è degna nemmeno di uno sguardo”.