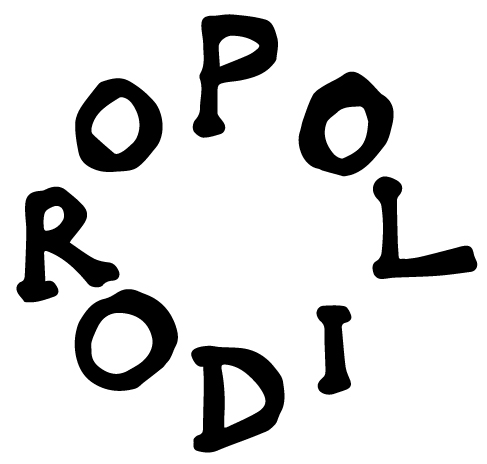Julie Polidoro è la principessa, il san Giorgio che la protegge, il drago che la tenta. Della principessa ha la gola bianca, i capelli biondi, la voce soave che sembra sempre in procinto di rompersi e cantare. Del santo cavaliere, la fronte alta, il portamento fiero, l’espressione severa e un po’ sdegnata. Del drago, la minacciosa irrealtà.
Competenti e incompetenti le dicono he quasi tutti i suoi quadri sono crocifissioni. Lei annuisce e risponde che le sembra giusto, che quando dipinge non ci pensa mai, che esclude i riferimenti religiosi (almeno quelli consapevoli), ma che le sembra giustissimo, “un giustissimo segreto”. E arrossisce per quello che le hanno detto, per quello che ha detto lei. Poi rinormalizza l’associazione con la forza della prassi: in effetti quel che le sta a cuore è l’ortogonalità, la interessano molto meno le diagonali, quasi indizi di una dilazione della scelta compositiva, tanto nei posti a tavola, nei panni appesi, negli stendini, quanto nei ritratti. Infatti per tutti i soggetti (persone o cose) preferisce inquadrature frontali o profili netti, ricusando scrupolosamente l’ambigua profondità del tre quarti.
Così dicendo è tornata pallida.
Julie Polidoro è così: timidissima e determinata, ingenua come una bambina un po’ tonta, spietata come un’artista di genio. Il decalogo della sua estetica, e il corollario delle sue tecniche, sono sobri e inderogabili: utilizza supporti di poco spessore (carta intelata, compensato, ha provato anche col metallo), che non realizzino oggetti da appendere al muro, ma campiture. Non lavora su tela perché la rugosità (dice “la rocciosità”) del tessuto le vieta il sommesso fluire della pennellata. Analogamente, i suoi colori sono un impasto di colla di pelle di coniglio e i pigmenti in polvere, che le consento di decidere momento per momento la pastosità del colore: non lavoro ad olio perché l’olio esclude l’opacità che lei predilige, squilla troppo.
Vuole infatti immagini non-narrative o che, comunque, raccontino a bassa voce; quadri di poche parole, che presuppongono scelte compositive molto precise e un rigore estremo nella selezione del frammento di mondo da rappresentare secondo formati primari (il quadrato o i multipli del quadrato, in orizzontale o in verticale). La finestra, struttura elettiva dei suoi fondi, ha la doppia funzione di determinare con esattezza la direzione della luce (“che il controluce sia un vero controluce!”), e di fornire un riferimento geometrico, una griglia che scandisca ritmicamente simmetria e simmetrie.
Il metodo che adopera per selezionare l’inquadratura le serve a eliminare la casualità della composizione, e le permette poi di abbandonarsi alle minute alee che intervengono nella pratica artigianale del dipingere.
Usa pennelli a pelo e a manico lungo impugnandoli con la mano arretrata, “per sentirmi – dice – più libera e più sorpresa di me stessa”: sintomi che tendono per lei a coincidere. Peri fondi adopera spazzole, che non sono precisissime nel tratto, ma definiscono la materia e i toni della materia.
Pratica la figurazione, ma, come nelle tele dei pittori che predilige, da Piero della Francesca a Rothko, figurativi o astratti che siano – e il discorso vale anche per le opere dei grandi fotografi -, giudica le sue immagini “molto mentali”. D’altronde, non la interessa dipingere se non d’après nature, perché a dipingere la eccita solo quello che ha sotto gli occhi, e lei guarda e riguarda da vicino, finché non ne vede affiorare la misteriosità. Le piace che “lo spettatore” (lei lo chiama così, chi guarda un quadro) si meravigli di qualcosa con cui ha condiviso una distratta intimità da tutta la vita: un indumento, una tavola apparecchiata, un termosifone, un limone. Aspira a conferire un potere agli oggetti, a dipingere “come è piatto un piatto, come sono posate le posate”. E come è denso il vuoto fra gli oggetti, come sono erotici il loro contatto, il loro non-contatto.
Se dipinge le cose come fossero persone, insomma, fa il ritratto delle cose, dipinge le persone come cose, nella sospensione del movimento. Ma, per i ritratti di persona, non lavora mai sulle foto: le danno poche informazioni sul reale, perché le hanno preselezionate. Lavorare da foto “è lavorare in un tempo fermo, in un tempo che è sempre lo stesso, senza la preziosa committenza della luce e della fretta”. E diffida del sorriso: “il sorriso – dice – non è vicino al silenzio, non tiene alla durata, è fuggevole”.
Ovviamente non la interessano i paesaggi: troppi elementi, troppo lontani, troppo complessi e praticamente immutabili rispetto al punto di vista del pittore. Le piace andare intorno alle cose che vede, sbirciarle, scrutarle, interrogarle, fino a scegliere l’”unica” inquadratura: vede male perché è, insieme, astigmatica e ipermetrope, e fa tesoro del fatto di poter vedere poche cose alla volta e di dover guardare centro volte la stessa cosa, per trovare in quella cosa le cento cose che prima non si erano lasciate vedere. “La libertà – dice – la raggiungo con la ripetizione, anzi se persevero mi raggiunge lei, naturalmente”.
Se le si chiede perché dipinge, la sua anima plurale – che ha in sé il rigore etico e l’ascesi imprenditoriale di un vecchio calvinista ma anche le languide pigrizie contemplative e i lunghi sonni di un poeta persiano – risponde: “E’ il mio lavoro, ci vivo, ho questa fortuna, e mentre dipingo sto benissimo, non ho bisogno di nient’altro, mi scordo di aver freddo, mi scordo di aver fame, mi scordo di aver voglia che qualcuno mi abbracci”.
Certo, davanti ai suoi quadri si rimane stupefatti dalla perentorietà di quel senso del vuoto, di quegli spazi di luce che sembrano città. Si rimane costernati davanti a tanta purezza: la desolata, brutale purezza delle cose.